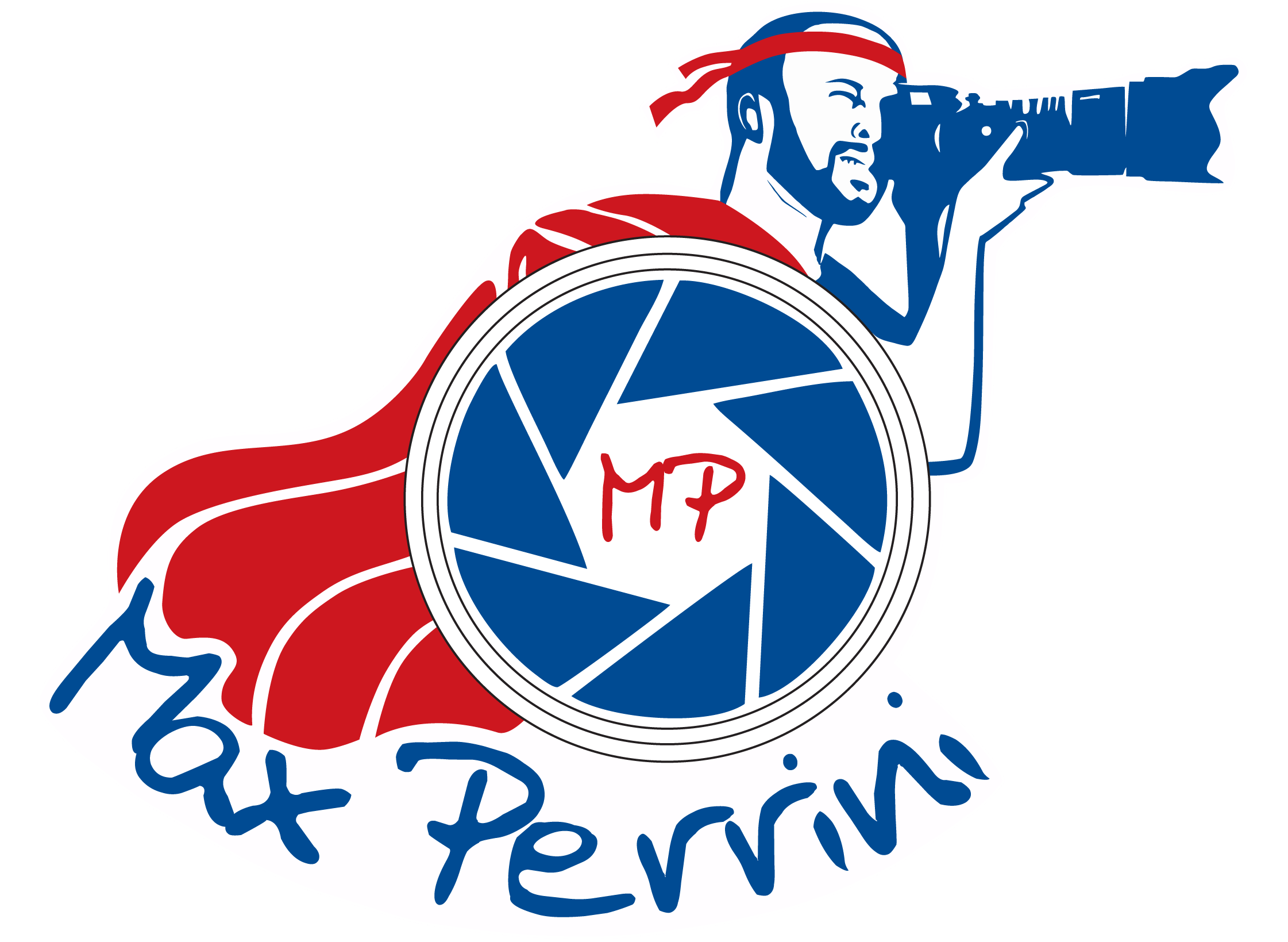Capitolo 7 – Il salotto perduto

Erano passate settimane dal suo arrivo in Degradoland. Thalassia si era immersa nel cuore delle comunità resistenti, aveva ascoltato il silenzio del Tara e il respiro del Mar Piccolo. Ma c’era una domanda che continuava a batterle dentro come un tamburo sommerso: com’era potuto accadere tutto questo?
Non solo la distruzione della natura. Ma anche quella dei luoghi che un tempo erano vissuti, amati, rispettati.
Quel mattino, lasciò l’Oasi all’alba, decisa a entrare nel ventre della città. Voleva vederla in faccia la ferita.
Camminò per via Fantasma, una strada che un tempo aveva avuto un altro nome, più nobile. Ora sembrava uno spazio intermedio tra l’abbandono e il silenzio. Le fioriere, arrugginite e rotte, non ospitavano più piante ma mozziconi di sigaretta, lattine ammaccate, bicchieri di plastica schiacciati. Qualcuno le usava per svuotarsi le tasche, altri per gettare il fondo di un cocktail bevuto male. I ragazzi, passando, ci lanciavano dentro cartacce come in un canestro.
Era il giardino dell’indifferenza, coltivato ogni giorno.
Più avanti, le piazze, un tempo vive di chiacchiere e mercatini, erano solo distese di sampietrini sconnessi e sedie rotte. Nessuno si guardava. Nessuno si fermava. Le relazioni erano evaporate come pozzanghere al sole: senza luoghi, non c’erano più incontri.
E senza incontri, si disimparava anche la gentilezza.
Alla fine della via, una sagoma familiare cominciò a stagliarsi contro il cielo.
Quando sollevò lo sguardo, lo trovò lì, imponente e immobile.
”Palazzo degli Uffici” o, come lo chiamavano ora, Il Salotto Perduto.
Un tempo era stato tutto: orfanotrofio, scuola, tribunale, cuore pulsante della città.
Ora era un blocco murato, annerito, con finestre cieche e portoni sbarrati. Un colosso vuoto che si sgretolava in silenzio, sotto gli occhi di chi ormai aveva smesso di guardare.
Mentre si avvicinava, vide una figura seduta su una panchina di ferro sbiadito. Era una donna anziana, composta, elegante in un modo che sembrava anacronistico.
Capelli raccolti, foulard al collo, uno sguardo che scrutava l’intonaco cadente come se lo stesse leggendo.
“Ci venivo ogni sabato, sai?” disse senza voltarsi.
“Mi sedevo lì, proprio sotto quella finestra. Aspettavo le amiche, prendevamo un caffè. Poi si parlava di libri, di figli, di politica. E si diceva ‘buongiorno’ agli sconosciuti.”
Thalassia la salutò con un cenno gentile.
“Lei viveva qui?”
“No, cara. Io abitavo qui. Che è diverso. Abitare vuol dire sentire un luogo. Oggi invece si passa e si consuma. Ci siamo consumati anche noi.”
Si presentò. Lucia Doria, ex professoressa. “Lettere classiche, e pure un po’ di storia. Adesso mi limito a raccontarla a chi ha voglia di ascoltare.”
“Questo palazzo…” iniziò Thalassia.
Lucia sospirò. “Questo palazzo è la nostra memoria fatta pietra. C’era il liceo Archita. Ci ha studiato la politica vera, quella che pensava in grande. C’era il tribunale, il centro meteorologico, le guardie urbane. Un tempo, questa era la mente di Taranto. Ora è solo una carcassa di bilanci falliti e appalti saltati.”
Fece una pausa, poi aggiunse:
“Lo hanno chiuso, murato, dimenticato. Promesso mille volte. Ristrutturato solo sulle slide dei convegni. Ogni volta un progetto nuovo, ogni volta un’altra bugia. E intanto… cade. Cade il palazzo, e con lui cade la cultura.”
Thalassia la guardò, in silenzio.
“E sai qual è la cosa peggiore?” continuò Lucia. “Che quando crollano i luoghi, crollano anche le relazioni. Non ci guardiamo più. Non ci ascoltiamo. Le piazze sono diventate scorciatoie. Le panchine sono vuote. I salotti sono diventati schermate.
Abbiamo perso i luoghi comuni, nel senso più profondo. E con loro, la fiducia.”
Rimasero lì, in silenzio, mentre una folata di vento muoveva le erbacce cresciute tra i gradini.
“Taranto non si salverà con i rendering,” concluse Lucia. “Si salverà solo con una rivoluzione culturale. Una vera. Che parta dalle parole gentili, dai gesti condivisi, dai luoghi che torniamo ad amare.”
In quel momento, un gruppo di bambini attraversò la galleria correndo. Uno di loro si fermò, raccolse una bottiglia di plastica da terra, e la buttò nel cestino più vicino.
Lucia sorrise. “Visto? Basta uno. Perché il degrado è contagioso, ma lo è anche la bellezza.”