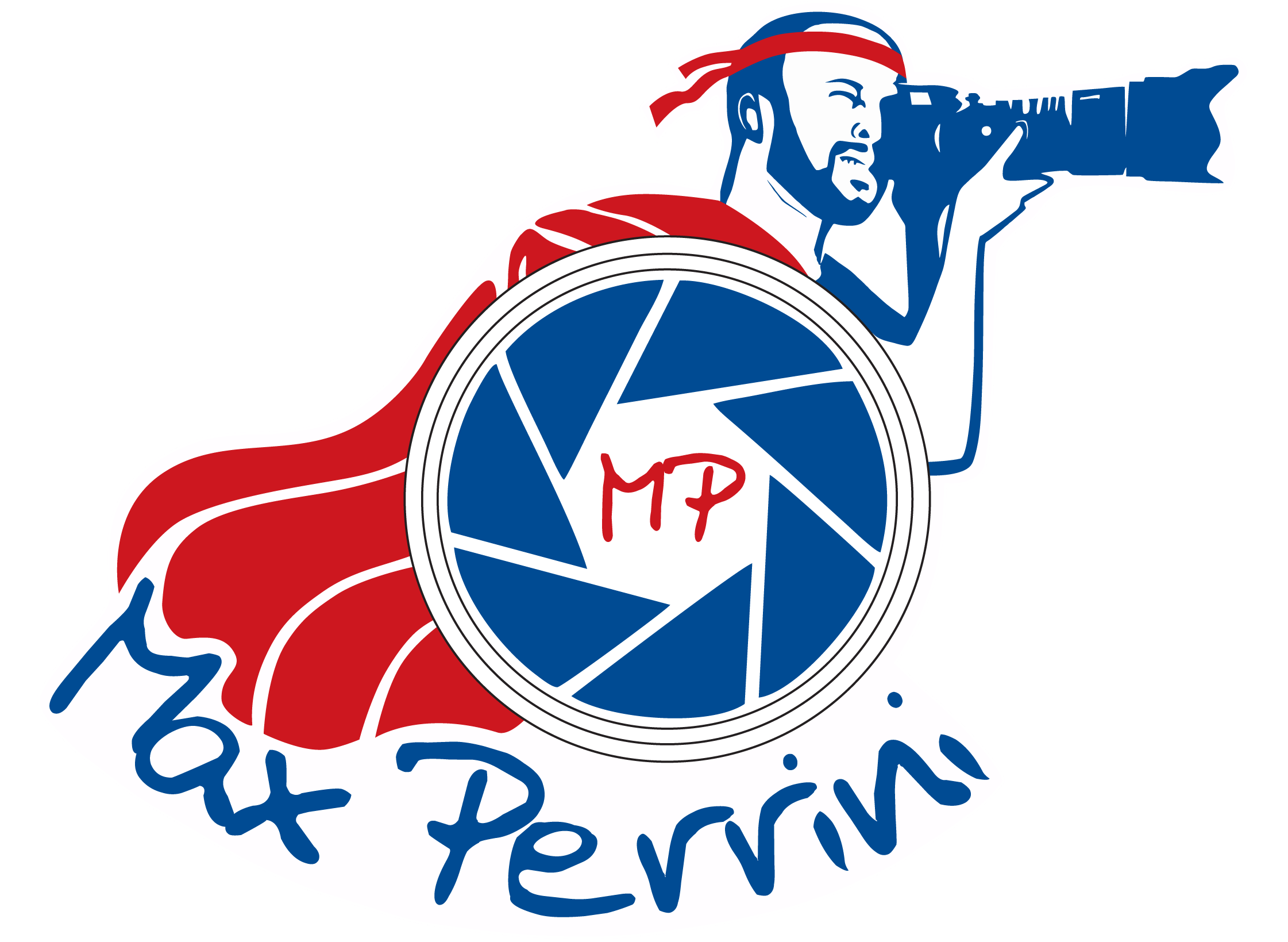Capitolo 10 - Le sentinelle di Zambegandia

Thalassia tornò a Zambegandia con un nodo allo stomaco e la polvere ancora viva negli occhi. Era passato più di un mese da quando aveva incontrato quelle ragazze e quei ragazzi lungo l’alveo secco del Tara. Più di un mese da quando aveva visto il corpo svuotato del fiume, la carcassa arrugginita del dissalatore, e i cartelli di legno piantati nella terra come croci in un cimitero che non voleva morire.
Non era riuscita a togliersi di dosso la voce di Lara, lo sguardo di Battista, il murale del bambino con la bottiglia vuota.
“Ci avete tolto l’acqua, ma non la sete.”
Quelle parole le bruciavano ancora in gola.
Il sentiero verso la Gravina del Triglio si faceva più stretto man mano che il giorno declinava. L’aria odorava di timo e pietra calda, mentre tra le fenditure delle rocce spuntavano cisti, corbezzoli, capperi. In basso, dove la luce si addolciva, le prime orchidee selvatiche ondeggiavano leggere, come piccole fiaccole nel crepuscolo.
Zambegandia prendeva il nome da due enormi gambe di cemento che spuntavano dalla terra come resti di un colosso caduto. Erano i vecchi silos dell’acquedotto e intorno a quelle gambe, ogni anno, i ragazzi si riunivano per il loro consueto clean up: un rito di resistenza, di appartenenza.
Quella sera, il tramonto colava lento sulle rocce della Gravina. Le Sentinelle si erano date appuntamento lì, nella gola antica dove la vegetazione cresceva fitta e il silenzio profumava di lentisco e memoria. Era una passeggiata, dicevano. Ma Thalassia sapeva che non c’era nulla di leggero in quel camminare.
Era un rito.
Nico, un ragazzo delle Sentinelle parlava, con il viso segnato dalla luce dorata e gli occhi pieni di un fuoco che non si poteva spegnere. Thalassia lo riconobbe subito. Lo aveva visto di sfuggita, quella volta al fiume. Ma ora era come se la sua voce avesse trovato il momento giusto per fiorire.
“Quel veleno che ci propinano non è solo ambientale,” disse. “È mentale. Ti convincono che non vali. Che tanto è sempre stato così. Che siamo nati qui per essere sacrificati.”
Fece una pausa. Nessuno fiatò.
“Ma noi non siamo rifiuti. Non vogliamo vivere come scarti. Vogliamo vivere, e basta. E per farlo… dobbiamo mostrare la bellezza.”
Quella generazione nata tra i fumi dell’industria, cresciuta a pane e polveri sottili, non si inginocchiava più. Aveva piantato radici nei luoghi dimenticati, nelle gravine e nei boschi, nei corsi d’acqua abbandonati dalle mappe e dalla politica. Aveva scelto di essere voce, non eco.
“Non serviamo bandiere,” disse un altro ragazzo, il volto abbronzato e gli occhi fieri. “Serviamo la terra che calpestiamo.”
Zambegandia era il nome che si erano dati, ma nessuno li aveva battezzati. Si erano nominati da soli. Con mani sporche di terra e occhi pieni di speranza.
Erano cresciuti a poche curve dalle ciminiere, nel Comune dove discariche e acciaierie avevano scavato più di un solco nella terra e nel destino. Avevano visto i tumori entrare nelle case come ladri, avevano ascoltato le promesse dei politici cambiare solo colore, mai sostanza. Avevano imparato a convivere con l’odore dolciastro del percolato e con le frasi fatte sulla transizione verde.
Ma non volevano più conviverci.
“Qui hanno seppellito veleni per anni,” disse una ragazza mentre attraversavano un sentiero scavato tra le rocce. “E ogni volta che apriamo bocca ci dicono che stiamo esagerando. Ma la vera sfortuna è rimanere zitti.”
Un tratto del cammino si apriva su una terrazza naturale. Sotto, la Gravina respirava con forza silenziosa. Le cripte scavate nella roccia, i muretti a secco avvolti di muschio, gli alberi di terebinto e il volo basso di un gheppio completavano un quadro antico e vivo. Una voce nel gruppo sussurrò: “È qui che si nasconde il futuro.”
La passeggiata si concluse in cima a una rupe, dove il panorama si apriva come una ferita e un abbraccio insieme. La Gravina del Triglio si mostrava in tutta la sua forza fragile: un lembo di terra incastonato tra diversi paesi della provincia. Una terra antica, piena di cripte e radici, ignorata da chi doveva proteggerla.
Un ragazzo tirò fuori il pane. Un’altra ragazza aprì una bottiglia di vino. La focaccia arrivò in cerchio, come in una messa laica della resistenza.
«Conoscerlo per difenderlo,» disse Enzo, un’altra sentinella, alzando il calice al cielo.
Thalassia sorrise, con un nodo alla gola. Pensava a tutto ciò che aveva visto in quei giorni: le radici intrecciate al carrubo, i pali del Mar Piccolo carichi di biodiversità, i resti del dissalatore, la biblioteca viva nel Salotto Perduto…
Ma fu lì, in quel momento semplice e sacro, che capì che non si trattava solo di denuncia.
Era amore.
Un amore testardo, ruvido, quotidiano. Un amore che cammina, che pulisce, che parla, che crea.
Quando il Comune murò le “Gambe”, il loro luogo, tentarono di chiuderli fuori. Ma loro, invece, avevano aperto ancora più forte i loro cammini.
Un ragazzo dal viso quieto si avvicinò. Portava con sé un piccolo involucro di stoffa.
“È un bulbo,” disse, porgendolo a Thalassia. “Un’orchidea selvatica. Quando troverai un luogo che merita di rifiorire, piantalo. Non serve tanto. Solo qualcuno che sappia aspettare.”
Thalassia prese il dono con la cura che si riserva a un gesto sacro. Non era solo un bulbo. Era un’alleanza. Una nuova.
La notte scese sulla Gravina come una coperta cucita di stelle. Il vento accarezzava le fronde leggere degli alberi, e nel silenzio, ogni radice sembrava sussurrare la stessa parola: rinascere.
E Thalassia capì che in quel luogo la lotta e la bellezza non erano due cose diverse.
Erano la stessa cosa.