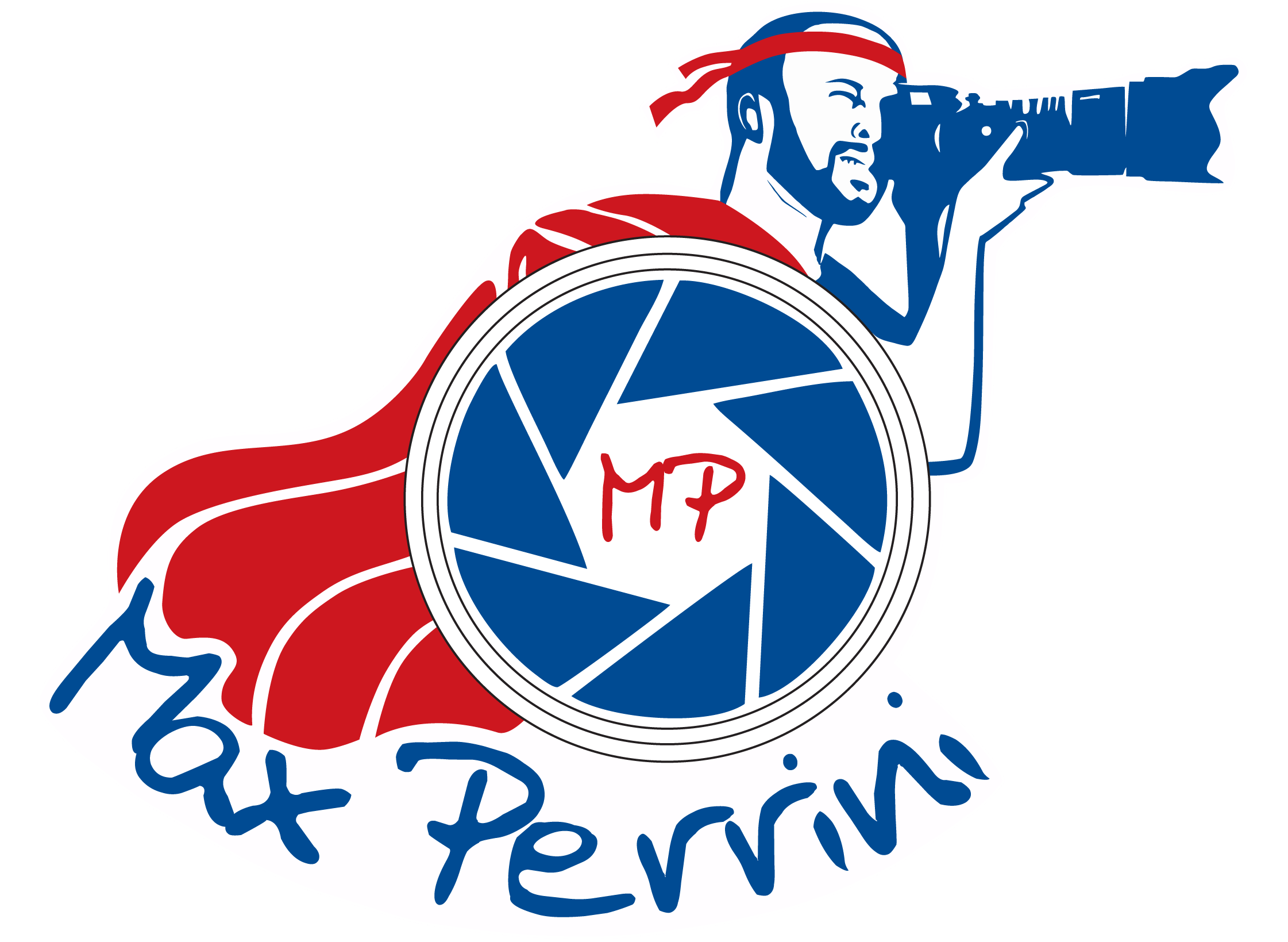Capitolo 11 - La principessa delle maschere

Il vento soffiava basso, denso. Non cantava tra le grondaie, non accarezzava le foglie. Grattava, invece, la pelle. Si insinuava tra le persiane chiuse, scivolava sotto gli infissi, appesantiva i respiri.
Era un Wind Day, uno di quelli segnati in rosso sul calendario come un presagio. A Degradoland nessuno li chiamava più così da tempo, ma nei registri dei medici apparivano ancora con quella dicitura: “Giorno a rischio. Polveri in aumento. Allerta per minori e anziani.”
Thalassia aveva imparato a riconoscerli anche senza previsioni. L’aria aveva un colore tutto suo, un odore che non si poteva nominare. Camminava a piccoli passi, il volto parzialmente coperto dal foulard che le aveva regalato Zane. Aveva promesso che sarebbe passata di lì, nel Quartiere delle Lanterne Spente, come lo chiamavano adesso. Ma un tempo si chiamava diversamente. E ancora prima, forse, Tamburi.
Lì, dietro un vecchio cancello in ferro, c’era il Giardino di Lulìa — non il nome vero, ma quello che avevano scelto i bambini. Era sorto su un fazzoletto di terra bonificata, piantato in mezzo alla polvere rossa come un atto di insubordinazione poetica. Alberi giovani, aiuole rialzate, una casetta-biblioteca con i vetri colorati. Dentro, a dirigere tutto con la serietà di un’anziana guida, c’era la Bambina delle Maschere.
Si chiamava Aria, ma nessuno la chiamava mai così.
Indossava una maschera fatta di cartone e fiori secchi. Ne realizzava una al giorno, diceva, come esercizio per respirare meglio. Le sue mani erano piccole, ma sapevano tenere insieme carta, colla e rabbia.
Quando vide Thalassia, le corse incontro.
«Lo sai che oggi è uno di quei giorni?» disse.
Thalassia annuì.
«Allora devi entrare. Quando il vento soffia così, non si sta fuori. Si fa memoria.»
La portò all’interno della casetta. Lì, un uomo anziano stava sistemando dei fogli su un tavolo rotondo. Indossava occhiali spessi, una giacca un po’ lisa, e parlava con voce pacata ma ferma. Lo chiamavano professor Marano, ma nel quartiere lo conoscevano come “quello che ha fatto domande troppo scomode”.
Aveva raccolto dati, scritto articoli, tenuto lezioni sotto i balconi. Era stato lui, anni prima, a spiegare che respirare può essere un atto politico. Che chi toglie l’aria a un quartiere, sta esercitando un potere. E che il silenzio, a volte, uccide più del fumo.
«Benvenuta, Thalassia,» disse. «Ti aspettavamo. I bambini hanno preparato qualcosa.»
Sul tavolo, una mappa disegnata a mano segnava i punti critici del quartiere. Le scuole chiuse. Le strade più colpite dalle polveri. I giardini mai completati. E accanto, maschere. Decine di maschere. Alcune colorate, altre con buchi neri per gli occhi. Nessuna uguale all’altra.
«Ognuna di queste,» spiegò Aria, «racconta una storia. Alcune non si possono più raccontare a voce. Altre non ce le fanno raccontare affatto.»
Thalassia accarezzò una delle maschere. Sentì la trama della carta, il nodo del cordino sul retro, il peso simbolico che portava.
«Perché le fate così?» chiese.
Fu il professor Marano a rispondere.
«Perché la voce ci è stata tolta troppe volte. Allora abbiamo imparato a scrivere senza parlare. A guardare negli occhi anche attraverso un cartone. A farci ricordare, quando altri provano a cancellare.»
Fu in quel momento che entrò un uomo in camice, le mani segnate dalle notti in corsia. Era il dottor Silvestri, medico del reparto oncologico pediatrico. Non parlava mai troppo. Quando lo faceva, ogni parola sembrava pesata come le dosi di un farmaco. Era andato lì, come al solito, per far visita ai suoi piccoli amici.
«Questa settimana,» disse piano verso il professore, «tre ricoveri nuovi. Due leucemie e una malformazione. Bambini sotto i sei anni. Il vento non perdona.»
Nessuno parlò. Thalassia sentì un nodo in gola, come polvere che si deposita e non se ne va.
«E i decreti?» domandò infine, «Quelli che chiamano “salva”…»
«Salva cosa?» replicò il professore, con un sorriso amaro. «Salvano l’acciaio. Il resto, brucia.»
Thalassia si avvicinò alla finestra. L’aria era ancora greve, ma dentro la stanza si respirava meglio. Non per l’aria filtrata, ma per la densità delle vite che si stringevano l’una all’altra. Per le storie che non chiedevano più il permesso.
Voltandosi verso il gruppo, prese la parola.
«Io sono arrivata qui dopo una congiunzione di stelle. Ma forse non è così strano. Forse le stelle si muovono solo quando qualcuno le chiama. Forse Degradoland non è solo un luogo. È lo specchio oscuro di ciò che può succedere quando si rinuncia alla bellezza, al coraggio, alla voce.»
Si avvicinò al tavolo, prese una maschera bianca e ci scrisse sopra una parola: Respiro.
«Non me la metterò per nascondermi,» disse. «La terrò per ricordarmi che ogni respiro è una scelta. E io ho scelto di restare. Di parlare. Di soffiare sulla brace.»
Il dottor Silvestri le fece un cenno di approvazione.
Il professor Marano annuì. «Accendere un fuoco, dunque.»
Thalassia sorrise. «Non solo. Questa volta non sarà una fiammella. Sarà un incendio buono. Una luce che non brucia, ma scalda. E che si vede anche da lontano.»
Fece una pausa, poi aggiunse, con voce più ferma:
«Per anni hanno detto che non c’era alternativa. Hanno chiamato “salvezza” la tutela dell’acciaio e non delle persone. Hanno barattato salute con produzione, dignità con profitto. E ogni firma in calce a quei decreti è stata una scelta. Politica. Consapevole. Chi ha deciso di salvare l’acciaio, sapeva. E ha voltato lo sguardo.»
Aria, la bambina delle maschere, si avvicinò a Thalassia e le porse un piccolo oggetto fatto di cartone e tulle: era una corona, leggera e fragile.
«L’ho fatta per quando qualcuno capisce.»
«Capisce cosa?» chiese Thalassia.
«Che qui non siamo solo vittime. Siamo radici. Siamo respiro. E siamo regine delle nostre storie.»
Thalassia la guardò, e per un attimo fu come se tutto il dolore del quartiere fosse stato raccolto in quella creatura minuta che creava bellezza con le mani.
In quel momento capì che non c’era titolo più giusto: lei era la principessa delle maschere. E dietro ogni cartone, c’era il volto di chi non aveva mai smesso di lottare.
In quel momento, fuori dalla finestra, il vento cambiò direzione. Nessuno osò dire nulla. Ma dentro quella stanza, qualcuno, forse, ricominciò a sperare.